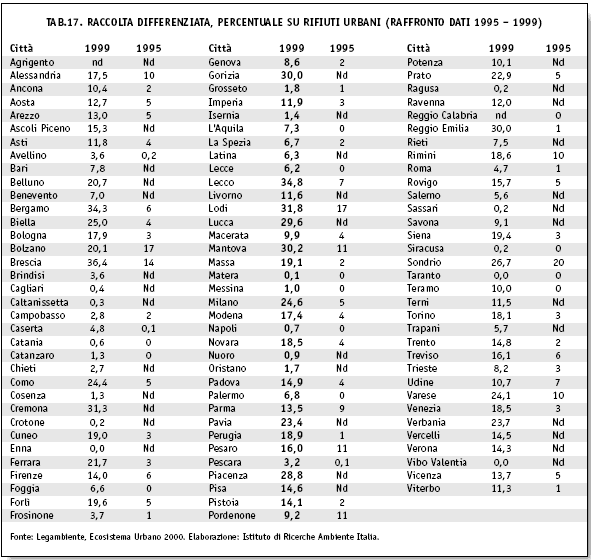![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Maria Rosaria Del Ciello Collaboratrice e ricercatrice rivista “Proteo”
Le privatizzazioni dei servizi nella Pubblica Amministrazione e negli enti locali
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
I rapporti prodotti dalla Commissione Bicamerale di inchiesta sui traffici illeciti di rifiuti, così come il lavoro svolto dall’Osservatorio ambiente e legalità in collaborazione con le forze dell’ordine riportano una tendenza a far viaggiare i rifiuti dal Nord verso Sud e questo è un punto di riflessione sulla gestione dei rifiuti nel nostro paese. Sempre a questo proposito va poi sottolineato che le autorizzazioni per il conferimento in discarica o in inceneritore vengono rilasciate alle imprese dalle regioni o dalle province sulla base di una richiesta riferita a quantitativi e tipologie di rifiuto da trattare e non in base ad una adeguata valutazione dell’effettivo fabbisogno del bacino. La ricerca di Legambiente, inoltre, fa rilevare che dal confronto dei dati relativi alle comunicazioni dell’effettiva produzione e dell’effettivo smaltimento rilevate tramite i MUD in ogni regione con le autorizzazioni rilasciate si conferma il dato già segnalato della non rispondenza fra il fabbisogno di smaltimento, la capacità autorizzata e la disponibilità impiantistica. Risultano infatti regioni quali la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, la Puglia e la Sicilia che a fronte di una capacità autorizzata allo smaltimento esportano i rifiuti prodotti verso altre regioni. Ci sembra importante fermarsi a riflettere sui risultati ottenuti da Legambiente perché forse più degli altri settori, quello dei rifiuti è facilmente preda di speculazioni: l’illusione che una gestione privatizzata del settore possa sanare le lacune fa presagire il pericolo che la logica del profitto prevalga sugli aspetti socio-sanitari che invece devono essere prevalenti nella gestione di tale settore.
Va da sé che tali ultime considerazioni vanno fatte anche nel caso degli altri servizi pubblici.
e) Settore energetico (elettricità e gas)
Una caratteristica peculiare della distribuzione del gas è la presenza tra i gestori di molti imprenditori privati accanto alle aziende pubbliche. Il Governo ha avviato la liberalizzazione del gas con la separazione societaria tra trasporto e distribuzione, e la possibilità di ingresso per distributori e clienti di piccole dimensioni (entro i 200 mila metri cubi annui). Vale la pena citare alcuni dati che chiariscono la struttura del settore. In quasi quattromila Comuni, pari a circa il 60% delle utenze, il servizio è fornito da operatori privati di cui solo 6 di grandi dimensioni tra cui Italgas che rappresenta circa il 30% del mercato. La forte presenza di operatori privati nel settore gas richiederebbe la necessità di norme che tengano conto delle particolari condizioni che verrebbero a crearsi nei casi di interruzione delle concessioni in essere considerato che queste superano di gran lunga l’eventuale periodo di proroga di cinque anni. Un altro aspetto critico è rappresentato dal passaggio dal vecchio gestore privato proprietario delle reti al nuovo a seguito di affidamento del servizio mediante gara pubblica. In tal caso si reputerebbe opportuno introdurre un sistema che garantisca l’indennizzo al gestore uscente degli impianti. Il riferimento al valore contabile degli impianti contenuto nel testo in discussione è inadeguato in quanto corrisponde in genere ad una sottostima del valore economico del bene. Preferibile appare il principio della valutazione a valore industriale degli impianti. La realtà delle aziende pubbliche e dei servizi pubblici locali (acqua, gas, rifiuti, elettricità, trasporti) si presenta ricca ed articolata ed infatti le aziende pubbliche locali si distinguono tra loro per numerosi aspetti. Ci sono i monopoli tecnici, come nel caso dei servizi a rete (gas, elettricità); esistono servizi (come i trasporti) caratterizzati da un elevato livello di concorrenzialità da parte di servizi succedanei (le auto private individuali); servizi che operano sostanzialmente in condizioni di mercato (come le farmacie comunali) e servizi in cui è evidente la presenza di esternalità (igiene ambientale) [1]. In tutti i casi, comunque, si sente una grande esigenza di controllo del territorio, di interventi qualificati, di estensione di servizi fondamentali, in altre parole di una grande capacità di programmazione. Paradossalmente, invece, si assiste ad una vera e propria "svendita" del patrimonio professionale e gestionale costruito dal pubblico in questi anni. Occorre invece rilanciare la necessità un ruolo d’intervento al "pubblico" in questi settori importanti e delicati, di puntare al governo del territorio coinvolgendo lavoratori ed utenti, rilanciando l’occupazione su questo terreno "di qualità". Bisogna difendere il lavoro, garantire l’occupazione; definire seri piani industriali per le aziende del settore; mantenere il controllo pubblico delle aziende del settore [2]. Nel caso della privatizzazione dei servizi pubblici locali il monopolio passerebbe dal pubblico al privato in quanto l’affidamento del servizio tramite gara, assegna al vincitore la gestione "monopolistica" da un minimo di 9 anni (per i trasporti) ad un massimo di 20 anni (ciclo delle acque). Inoltre le tariffe, saranno determinate dalle imprese gestori, in relazione al rientro degli investimenti. Si innesca il meccanismo della competitività, obbligando le imprese pubbliche a ridurre i costi di gestione, agendo sul costo del lavoro, mettendo a rischio l’occupazione e i livelli salariali, nonché il quadro di tutela dei diritti del secondo livello contrattuale. Sarebbe invece preferibile modificare il testo del d.d.l. 7042 reintroducendo l’autonomia di scelta da parte degli enti locali in relazione alle forme di gestione, mantenendo in tal senso il testo originario dell’art. 22 della legge 142/90; così come sarebbe auspicabile che tra le facoltà dell’ente locale vi sia anche la procedura di affidamento diretto dei propri servizi a propri enti strumentali o a società a prevalente capitale pubblico. I soggetti interessati alla riforma e cioè l’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), l’Unione delle Provincie Italiane, l’Uncem (Unione Nazionale delle Comunità Montane), la Cispel (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici Locali), la Confindustria e l’Eni, tutti sia pur con diverse sfumature, hanno condiviso la scelta legislativa di selezionare l’offerta di servizi pubblici locali a rilevanza industriale (erogazione di energia non elettrica, erogazione del gas, gestione del ciclo dell’acqua, gestione dei rifiuti solidi urbani e servizi di trasporto collettivo) attraverso lo svolgimento di gare pubbliche. Soltanto Anci e Cispel in merito alla modalità di affidamento del servizio hanno difeso, in nome della discrezionalità amministrativa, il principio della scelta fra affidamento diretto e gara.
4. Riflessi sul mondo del lavoroOltre che per l’ammontare e la tipologia delle prestazioni la Pubblica Amministrazione presenta un notevole interesse economico anche per il volume di occupazione assorbito e, quindi, per l’influenza che esercita nel mercato del lavoro. Le politiche di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione, attuate nel corso degli anni 90, hanno profondamente inciso anche e soprattutto sull’occupazione che si presenta oggi profondamente modificata e deteriorata, con un tasso di disoccupazione ancora a due cifre e tra i più alti in Europa; una crescita del lavoro nero e in generale del lavoro povero, precario e privo di tutele; un tasso di occupazione della popolazione in età lavorative tra le più basse tra tutti i paesi industrialmente avanzati, che penalizza soprattutto le donne (il cui tasso di partecipazione al mercato del lavoro in Italia supera di poco il 34%), i giovani e le popolazioni meridionali. Attualmente nell’area dell’OCSE i disoccupati raggiungono i 36 milioni di unità, pari all’8% delle forze di lavoro, e il fenomeno presenta sicuramente un aspetto di persistenza. Va detto che, a partire dagli anni ottanta la forza contrattuale dei sindacati e dei lavoratori è scemata. “All’eccesso del rapporto salario/produttività rispetto a una norma di pieno impiego è seguita una redistribuzione del reddito a favore del profitto” [3]. E questo ha reso possibile il sopravvento dell’economia capitalista sull’economia “sociale”: il mercato è stato così reinterpretato solo in termini di saggio di profitto, il quale postula a sua volta efficienza nel processo produttivo senza tener conto degli aspetti socio-redistributivi che invece sono determinanti se si vuole tener conto anche dell’altro aspetto della medaglia, ovvero l’equità. Questo sopravvento del profitto sul salario, a tutto danno, ovviamente, della classe lavoratrice e, ancor più, della classe dei disoccupati, trova terreno fertile nella caduta di generosità dei sistemi di protezione sociale (fenomeno oggi sempre più diffuso in tutte le aree geografiche). Inoltre “sebbene il peso del terziario sia cresciuto ovunque, l’integrazione internazionale più stretta, l’emergere di nuovi ruoli, le politiche antitrust e di deregolazione hanno probabilmente intensificato la concorrenza nei mercati del prodotto” [4] e tale percezione si è estesa ai rapporti di lavoro. “Alla cautela delle famiglie nella spesa per consumi non sono estranei i timori di riduzione delle garanzie nel rapporto di lavoro e nel sistema di protezione sociale; la flessibilità dell’occupazione accresce a propria volta l’incertezza delle prospettive”. [1] Antonio Di Majo (a cura), "Le politiche di privatizzazione in Italia. 3° Rapporto CER/IRS sull’industria e la politica industriale italiana", Il Mulino, 1989. [2] Marco Gelmini, Le trasformazioni nel settore energia, in: www.rifondazione.it/energia. [3] Ciocca Pierluigi (a cura di), “Disoccupazione di fine secolo. Studi e proposte per l’Europa”, Torino, Bollati Boringhieri, 1997. [4] Ciocca Pierluigi (a cura di), “Disoccupazione di fine secolo. Studi e proposte per l’Europa”, Torino, Bollati Boringhieri, 1997.
|